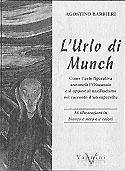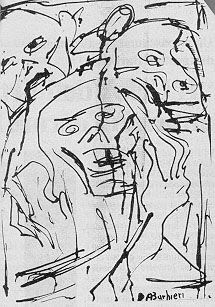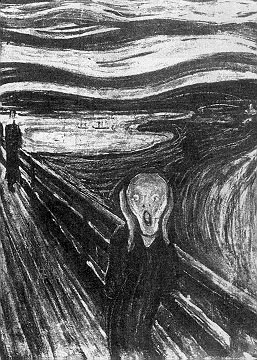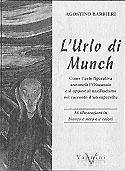
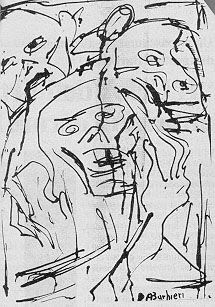
Agostino Barbieri, Mauthausen 1948.
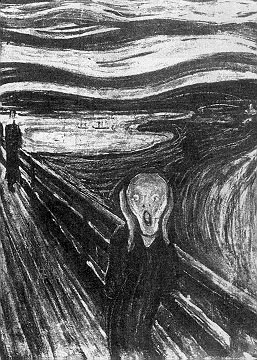
Edvard Munch, "L'urlo", 1893

Aligi Sassu, "I martiri di piazzale Loreto", 1944
|
Di fronte ad una copia fedelissima dell' "Urlo" di Edvard
Munch, Agostino Barbieri resta inchiodato davanti a quella figura dalla
bocca spalancata che si porta le mani alle orecchie per non sentire
il grido di dolore e di disperazione: "Se è vero,com'è
vero - osserva - che l'arte anticipa i tempi, Munch con questo dipinto
ha previsto le terribili conseguenze che l'ideologia nazista avrebbe
prodotto nel mondo. L'Urlo è l'eco anticipata di tutte le grida,
le invocazioni, le disperazioni, le maledizioni di milioni di esseri
umani sacrificati sull'altare dove si innalzava, non la croce simbolo
della cristianità, ma quella uncinata della violenza, della barbarie."
Agostino Barbieri è un artista sensibile, un pittore che ha esposto
le proprie opere in numerose mostre in Italia e all'estero. Ma è
anche uno che, dopo aver partecipato alle campagne di Jugoslavia, Russia
e alla Resistenza, venne deportato nel campo di sterminio di Mauthausen.
In questo suo libro, che si intitola, per l'appunto, "L'Urlo di
Munch", pubblicato dall'editore Vannini, Barbieri rievoca con una
intensa prosa, sempre sospesa fra la memoria e la realtà, le
proprie esperienze, rivendicando all'arte figurativa, non soltanto con
Munch, ma anche con Grosz, Dix, Rouault, Kokoschka, Fougeron, Guttuso,
Mafai, Manzù, Levi e tanti altri, il merito di avere annunciato
le mostruosità del nazismo, opponendosi con inflessibile determinazione
a quel feroce regime di morte. "Anche l'arte - rammenta Barbieri,
citando Hermann Bahr - urla nelle tenebre, chiama al soccorso, invoca
lo spirito: è l'Espressionismo".
Barbieri ripropone vicende, cita testimonianze dell'orrore, quando nei
campi di sterminio tutto era possibile, quando il destino di milioni
di innocenti era nelle mani di aguzzini come il dottor Mengele. "Lo
vidi - rammenta un'infermiera - prendere ogni precauzione durante un
parto, verificando che tutto fosse scrupolosamente in ordine e che le
regole per il buon esito del parto fossero rispettate. Mezz'ora dopo
fece mandare madre e figlio ai forni crematori".
La Germania, per fortuna, non era solo Hitler, anche se il suo delirio
criminale coinvolse la stragrande maggioranza dei tedeschi, trasformando
molti di essi in feroci carnefici. La Germania era anche Thomas Mann
e Bertolt Brecht, i già citati Otto Dix e Ernst Barlach. Un'altra
grande artista - scrive Barbieri ricordando ciò che di lei è
stato detto - è Kathe Kollwitz, la cui opera "è il
più grande poema che riflette le prove e i dolori degli umili
e dei semplici.
Questa donna dal cuore virile li ha raccolti nei suoi occhi e nelle
sue braccia materne. Ella è la voce del silenzio dei popoli sacrificati".
Per Hitler e Goebbels le opere di questi artisti erano "arte degenerata",
un'arte da mettere alla gogna, da additare al pubblico disprezzo in
una mostra - tristemente famosa - che venne organizzata a Monaco. Ricorda
Barbieri che sparirono allora oltre diecimila opere dei maggiori artisti
tedeschi ed europei e che nel cortile della caserma dei pompieri di
Berlino andarono al rogo un migliaio di dipinti ad olio e circa quattrocento
acquarelli. Un passato orrendo, che non deve essere dimenticato. Barbieri
lancia il drammatico monito, ricordando l'affermazione del filosofo
madrileno George Santavana: "Chi cerca di dimenticare il passato
è condannato a riviverlo". Un'opera importante e utile,
dunque, quella di Agostino Barbieri, che ha il pregio di mantenere vivo
- come osserva Dino Formaggio, professore emerito della facoltà
di lettere e filosofia dell'Università di Milano nella prefazione
- il ricordo di un infinito dolore e delle profonde ferite subite dai
propri "simili".
Agostino Barbieri
"L'Urlo di Munch",
Vannini editore,
pp. 183, lire 25.000
|