La carriera di un gerarca |
Da feroce aguzzino della Gestapo a Milano ad agente della Cia e del governo di Bonn |
|
L'ex comandante dell'Aussenkommando di Milano commenta il verdetto: "E' una montatura, sono un uomo piccolo così". |
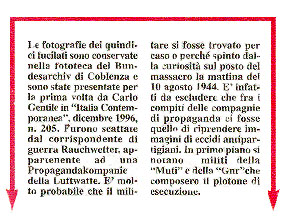 |
 |
| Un potente gerarca del Terzo Reich. Comandante dell'Aussenkommando di
Milano, il commissariato della Gestapo, spietato "governatore"
di San Vittore e dell'Hotel Regina, l'SS-Hauptsturmfuehrer Theodor Emil
Saevecke aveva 32 anni quando arrivò per la prima volta nel cuore
della Lombardia, culla della Resistenza. In diciannove mesi e diciassette
giorni, dal settembre del '43 all'aprile del '45, tanto durò il
suo regno di tremendo aguzzino, Milano visse una stagione di terrore e
di sangue. Ex dirigente della Schilljugend di Rossbach, commissario della
polizia criminale di Berlino, con le SS in Polonia, Libia ed in Tunisia
prima che il colonnello Walter Rauff lo trasferisse in Italia, Theo Saevecke,
classe 1911, è ora un tranquillo signore di 88 anni che vive a
Bad Roithenfeld in Bassa Sassonia, pensionato dal 1971 dopo aver prestato
i propri servigi alla Cia (1948) e aver percorso una brillante carriera
nella polizia di Bonn. Strappato al suo quieto vivere, ricacciato con
il peso dei suoi crimini in un passato che non aveva mai rimosso, davanti
all'accusa dell'eccidio di piazzale Loreto, aveva reagito infastidito:
"E' una montatura, quel magistrato italiano non ha alcun diritto
di frugare nelle pieghe della mia vita. Sono già stato assolto
molti anni fa dai tribunali inglesi e tedeschi. E poi rispetto ad altri
sono un uomo piccolo così".Theo Saevecke è stato tutt'altro
che una rotellina nel micidiale ingranaggio nazista e, una volta smascherato,
aveva goduto di forti protezioni: il governo tedesco negli anni sessanta
aveva aperto un'inchiesta contro di lui ma l'aveva poi chiusa senza conseguenze.
Era il 15 marzo 1963 quando il consigliere di Stato Gerhard Wiedemann
fu inviato in Italia per cercare di far chiarezza sullo scandalo che aveva
spazzato la Germania come un uragano. Si trattò di un'istruttoria
ricca di testimonianze che erano state qualche anno prima già raccolte
da Giovanni Melodia, segretario generale dell'Aned, nella faticosa opera
di ricostruzione della dolente memoria storica dei sopravvissuti. Una
foto, ritrovata in modo fortunoso dal Comitato combattenti antifascisti
di Berlino ed inviata a Milano per il riscontro, aveva contribuito a togliere
ogni dubbio. Saevecke era emerso a tutto tondo dai ricordi delle vittime
come un criminale che, direttamente o indirettamente, aveva coordinato
ogni repressione a cominciare dalla strage di Meina sul lago Maggiore
del 22 settembre 1943, quando 54 ebrei vennero massacrati da appartenenti
alla Divisione corazzata "Adolf Hitler". Saevecke aveva potuto
contare su una rilevante struttura poliziesca: venti ufficiali, sessanta
sottufficiali fra cui il sergente Walter Gradsack, detto "il macellaio",
il maresciallo capo Helmuth Klemm, il caporal maggiore Franz Staltmayer
noto come "il porcaro", venti soldati oltre ad un nutrito numero
di militi italiani addetti alla sorveglianza. Il modello dell'AK Mailand
era simile a quello di Berlino: punti di forza, l'Ufficio III (SD) per
la repressione partigiana ed operaia e l'Ufficio IV con la sezione B4
per la caccia agli ebrei gestita dal maresciallo Otto Kock (da non confondere
con Pietro Koch, il massacratore italiano di Villa Triste). Saevecke non
si era limitato a impartire ordini, spesso aveva preso parte ai pestaggi
e alle torture. Le carte del processo propongono scenari agghiaccianti,
l'elenco dei martiri è lunghissimo, da Poldo Gasparotto (caduto
poi a Fossoli) a Vittorio Bardini, combattente di Spagna; da Manfredo
Dal Pozzo ad Antonio De Bortoli; dai gappisti Alfonso Cuffaro e Alfonso
Montuoro a don Achille Bolis; da Antonio La Fratta ad Erich Wacthtor;
da Salomone Rath, sbranato da una cane durante un interrogatorio, a Tullio
Colombo e Carlo Mallowan uccisi a bruciapelo, a Egisto Rubini, a molti
altri ancora. Basti il ricordo di Aldo Ravelli, agente di borsa, fermato il 23 dicembre 1943 per favoreggiamento degli ebrei, selvaggiamente percosso a San Vittore, poi trasferito nei campi di Bolzano-Gries, Mauthausen, Gusen. "Tutti i giorni - aveva rivelato Ravelli all'inviato di Bonn Gerhard Wiedemann - c'erano dei prigionieri massacrati di botte da parte dei marescialli dell'Hotel Regina. Klemm e Staltmayer mantenevano l'ordine con il terrore. Le bastonature erano così frequenti che per noi era una novità quando non c'erano dei massacri". Ai sabotaggi e alle azioni partigiane aveva risposto il Comando SS con una serie di stragi in un luglio di sangue: il 15 tre fucilati a Greco, il 20 altri tre a Corbetta, il 21 cinque fucilati e cinquantotto deportati a Robecco sul Naviglio, il 31 sei fucilati al Forlanini.Ma perché il 10 agosto la carneficina di piazzale Loreto se nell'esplosione del camion della Wermacht in viale Abruzzi due giorni prima non c'erano state vittime tedesche? Perché l'ordine alla Gnr e alla "Muti" di fornire un plotone d'esecuzione per quel gruppo di antifascisti innocenti? La risposta era nella paura: se da una parte i tedeschi temevano assai vicina l'insurrezione, i fascisti vedevano i gappisti di Giovanni Pesce in ogni strada. Piazzale Loreto con i quindici caduti strappati da San Vittore, Greco, Robecco e Forlanini, era stata la tappa di un piano preciso. "All'escalation del clima insurrezionale - scrive Luigi Borgomaneri nel suo esemplare Hitler a Milano - deve corrispondere l'escalation del terrore prima che l'aggressività partigiana dia fuoco alle polveri della combattività operaia. Non a caso nell'arco di poco più di tre settimane si comincia con tre fucilati, poi si passa a sei ed infine a quindici". Una strategia che non avrebbe retto alla verifica del campo. La guerriglia partigiana, infatti, pur segnata da perdite dolorose, alla fine si sarebbe imposta. Mussolini, del resto, informato dell'eccidio di Milano, pare abbia commentato a caldo: "Il sangue di piazzale Loreto lo pagheremo molto caro". |